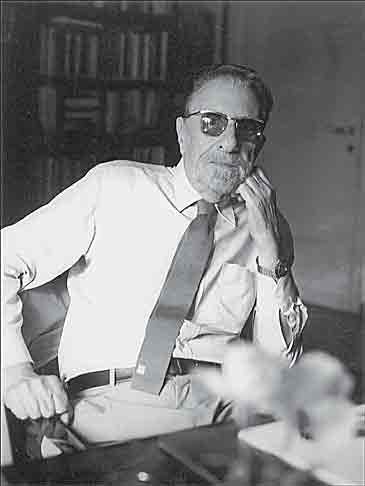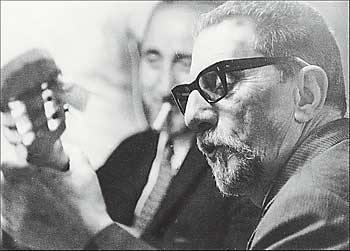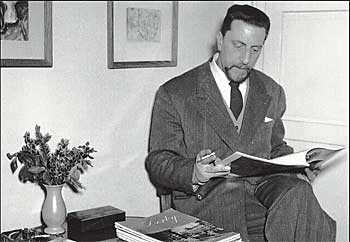Marco Pola:
IL "POETA DI TRENTO"
di Alessandro Franceschini*
Cento anni fa nasceva a Roncegno (nella Valsugana, in Trentino)
Marco Pola. Il "poeta di Trento", così come
era conosciuto nell'ambiente letterario italiano (secondo la
definizione di Vanni Scheiwiller, l'editore di poesia per antonomasia),
rappresenta una delle figure più interessanti del panorama
poetico nazionale del Novecento. Marco Pola attraversa il "secolo
breve" con la sua sensibilità, grazie ai versi della
sua poesia, osservando, leggendo e catalogando il mondo che
lo circonda. Una realtà che a tratti è rigidamente
statica e a tratti è caratterizzata da una continua,
incessante, brutale trasformazione. Fu autore di una produzione
poetica vastissima che conta quaranta raccolte di poesie in
lingua e in dialetto (più di mille poesie), pubblicate
tra la fine del Ventennio e la conclusione della Guerra Fredda.
Nato e cresciuto nell'ambiente prebellico dagli echi asburgici
della Roncegno di inizio secolo, Pola vedrà ben presto
il mondo idilliaco della fanciullezza frantumarsi sotto il peso
delle bombe del primo conflitto mondiale. L'esperienza di profugo
a Katzenau lo accomuna a molti altri trentini e recide il legame
con un luogo e un tempo di pace e di serenità ai quali
tenderà per tutta la vita. Il fallimento del Fascismo,
visto dal giovane poeta come una speranza dei tempi nuovi, e
del Futurismo, al quale aveva affidato i suoi primi virgulti
poetici, segnano una ulteriore spaccatura che viene definitivamente
dilaniata dallo scoppio della Seconda Guerra mondiale. Eventi,
questi, che lo porteranno ad un silenzio lungo diciotto anni,
fino alla metà degli anni Cinquanta.
Dopo questa pausa di studio, di ricerca identitaria e di riflessione
poetica, Pola si riaffaccia alla stampa con un nuovo approccio
al mestiere del poeta. E' infatti più strutturato e padrone
di uno stile chiaro e maturo. E nel frattempo ha ampliato i
suoi contatti e le sue amicizie con poeti, editori e letterati
del Veneto, del lombardo e della capitale. Dal 1956 (anno in
cui esce Quando l'angelo vuole) i libri escono con una cadenza
triennale che si intensifica quando, a partire dal 1963 (allorché
viene pubblicata la silloge Le fize del sofà), comincia
a scrivere anche in lingua dialettale.
Il dialetto adottato da Pola è quello parlato nella città
capoluogo, l'"idioma" più colto - quasi una
lingua nazionale della Regione - che si rivela uno stile comunicativo
efficace, tanto da sorprendere lo stesso poeta, affacciatosi
all'esperienza quasi per gioco. E', infatti, con il dialetto
che l'Autore, pur partendo da un recupero della tradizione popolare,
apporterà le innovazioni più significative nella
poetica trentina, trasformando un linguaggio relegato alla cantilena
e allo sberleffo in un valido metodo di espressione delle passioni
e dei turbamenti più segreti.
Dopo il nuovo inizio simbolista che caratterizza la produzione
poetica degli anni Cinquanta, Pola si avvale dunque dell'idioma
dialettale come strumento adeguato alla ricostruzione realistica
di quei mondi spazzati via dalle guerre, consentendogli di arrivare
ai vertici più significativi della sua ispirazione. Tuttavia,
nonostante la scoperta di questa nuova e pregnante maniera di
scrivere e descrivere la realtà e le dimensioni più
autentiche sottostanti ad essa, anche l'impegno nella poesia
in lingua prosegue con vigore. A partire dalla fine degli anni
Settanta, quindi, la produzione poetica di Pola si muove lungo
i due binari della lingua italiana e del dialetto. Il poeta
trentino riserva il primo alla produzione "civile",
mentre il secondo è più spesso utilizzato nell'espressione
degli umori viscerali e per dar voce al senso del divertissment.
Verso la fine della sua esistenza, il divario tra i due moduli
si allarga sempre più, fino all'abbandono del dialetto
nel 1989 quando la poesia impegnata in lingua raggiunge livelli
altissimi nelle ultime due raccolte, Autunno e maschere (1989)
e Il sonno delle lucertole (1991).
M' illumina un presentimento
di stillanti arcipelaghi adagiati
sotto l'enorme sole,
mentre la morte dei roseti è certa.
Ma i cantieri son silenziosi.
Bianchi scheletri di navi
spezzano ogni mio dolce piano.
Io morirò fra le ossessioni
dei monti giganteschi.
L'urogallo altrove, 1971