A Madonna di Campiglio l'innovativo sistema
di riscaldamento domestico che sfrutta le viscere della terra.
Scenario energetico:
fonti rinnovabili e geotermia
di Ivan Castellani*
 Il
problema energetico costituisce ormai pane quotidiano sia
per la grande industria che per l'utente medio-piccolo, come
l'artigiano o il privato cittadino. L'attuale scenario europeo
e nazionale presenta almeno due principali filoni di consumo:
termico da combustione ed elettrico, dipendente a sua volta
in certa misura dai combustibili fossili quali petrolio, gas
naturale e carbone. Il
problema energetico costituisce ormai pane quotidiano sia
per la grande industria che per l'utente medio-piccolo, come
l'artigiano o il privato cittadino. L'attuale scenario europeo
e nazionale presenta almeno due principali filoni di consumo:
termico da combustione ed elettrico, dipendente a sua volta
in certa misura dai combustibili fossili quali petrolio, gas
naturale e carbone.
Con il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Bersani),
che ha liberalizzato il settore energetico, è nato
in Italia il mercato elettrico, a seguito del quale è
possibile, per gli utenti idonei, acquistare e vendere energia
elettrica nella borsa dell'energia, ove vigono le regole della
concorrenza. Idonei sono, a partire dal 2004, tutti i titolari
di partita IVA ossia qualsiasi cliente diverso dalle utenze
domestiche. Queste ultime rappresentano l'utente vincolato,
che non può stipulare in prima persona contratti di
fornitura con un distributore qualsiasi, ma è obbligato
a rifornirsi da quello che esercita il servizio nel proprio
territorio. Il garante di mercato di tali utenti è
l'Acquirente Unico (AU), che assicura la disponibilità
e la fornitura di energia con continuità, sicurezza
e parità di trattamento tariffario, stipulando contratti
sia di vendita che di acquisto sul mercato. Dal 1 gennaio
2007 diverrà idoneo qualsiasi cliente finale, anche
i domestici.
Rilievo ambientale sempre maggiore hanno assunto le fonti
rinnovabili di energia (eolica, solare, geotermica, del moto
ondoso, idraulica, da biomasse, da biogas, …). Fra le
misure di incentivazione è il caso di ricordare lo
strumento dei certificati verdi (CV), introdotti nel 1999
e rilasciati dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale
(GRTN), che attestano che una quota di energia (espressa in
Kilowattora: KWh) messa sul mercato da un produttore proviene
da fonti rinnovabili. Tali certificati, di taglia 50.000 KWh,
sono a tutti gli effetti dei titoli quotati sul mercato dell'energia.
L'incentivo sta nel fatto che vi è l'obbligo, per produttori
ed importatori, di immettere sul mercato annualmente una quota
di energia da fonte rinnovabile pari al 2% del totale prodotto
nell'anno precedente. Dal 2004 al 2006 la quota d'obbligo
è incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali.
Chi produce (o importa) energia elettrica prodotta da fonti
non rinnovabili può adempiere all'obbligo con l'acquisto
sul mercato di CV relativi alla produzione effettuata da altri
soggetti in eccedenza alla loro quota d'obbligo. L'obiettivo
italiano è il raggiungimento del 25% di consumi elettrici
da fonti rinnovabili entro il 2010.
Il processo di decentramento della politica energetica ha
conferito molte competenze alle Regioni e alle Provincie Autonome:
localizzazione di impianti di teleriscaldamento, certificazione
energetica degli edifici, limitazione delle emissioni di gas
serra e così via. Il Trentino si situa, sul panorama
nazionale, ai primi posti per quanto riguarda la produzione
di energia da fonte rinnovabile, quasi tutta ottenuta da impianti
idroelettrici.
Facendo uno zoom sulle utenze domestiche, nella Provincia
di Trento, un caso di ottimizzazione delle risorse naturali
con particolare attenzione all'aspetto ambientale va segnalato
a Madonna di Campiglio. Si tratta dell'Hotel Garni del Sogno.
Tenuto conto della necessità di riscaldamento per gran
parte dell'anno a causa del clima locale, l'incidenza dell'utilizzo
di fonti che non comportano combustione, costituisce di per
sé un bonus notevole, anche se nella fattispecie non
riguarda la produzione di energia elettrica ma di calore.
L'impianto di riscaldamento, realizzato dall'Ingegner Schiavon
e che costituisce il primo esempio nel suo genere nella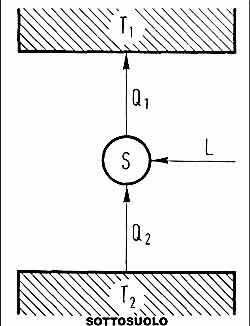 provincia di Trento, abbinato a un attento isolamento termico
dell'edificio, utilizza l'energia geotermica immagazzinata
nel sottosuolo sotto forma di calore. Si tratta di un concetto
molto semplice, la cui messa in opera non necessita di particolari
condizioni ambientali. Nel sottosuolo, e in particolare nella
falda acquifera, è immagazzinato calore dovuto alla
radiazione solare e, ciò che è più importante,
questo serbatoio, a determinate profondità, si mantiene
a temperatura pressoché costante per tutto l'anno.
provincia di Trento, abbinato a un attento isolamento termico
dell'edificio, utilizza l'energia geotermica immagazzinata
nel sottosuolo sotto forma di calore. Si tratta di un concetto
molto semplice, la cui messa in opera non necessita di particolari
condizioni ambientali. Nel sottosuolo, e in particolare nella
falda acquifera, è immagazzinato calore dovuto alla
radiazione solare e, ciò che è più importante,
questo serbatoio, a determinate profondità, si mantiene
a temperatura pressoché costante per tutto l'anno.
Si tratta di trasferire tale calore fornito gratuitamente
dalla natura, opportunamente amplificato, all'ambiente interno
all'edificio, tramite una pompa di calore.
Ma cos'è una pompa di calore? Tutti abbiamo familiarità
con il frigorifero: esso sottrae calore a un ambiente freddo
(chiamato sorgente fredda), ossia il suo interno, per cederlo
a un altro ambiente più caldo (sorgente calda), quello
esterno. Ora, la temperatura del sottosuolo è di pochi
gradi mentre quella interna all'edificio è superiore.
Dato che il trasferimento di calore da una zona fredda a una
più calda non può avvenire spontaneamente, c'è
bisogno di un "aiuto" esterno, rappresentato dall'energia
elettrica la quale fa funzionare un motore (compressore) adatto
allo scopo. La pompa di calore è esattamente un frigorifero,
solo che è diverso lo scopo finale: non più
sottrarre calore a un ambiente freddo per raffreddarlo ancora
di più (il sottosuolo), ma cedere calore ad un ambiente
caldo (acqua sanitaria e di riscaldamento). La sorgente "fredda"
è il sottosuolo, con la falda acquifera a circa 10°C
costanti in quanto, poiché essa scorre, la zona è
soggetta a un continuo ricambio di acqua con la stessa temperatura
in arrivo (capacità termica idealmente infinita), mentre
la sorgente calda è l'acqua che circola nell'impianto
di riscaldamento. Il maggiore rendimento, e quindi la maggiore
convenienza, si ha quando le temperature delle sorgenti (T1
e T2) sono vicine.
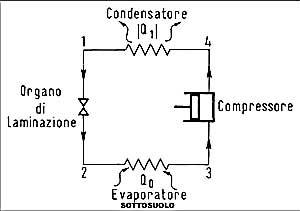 L'installazione ha un costo maggiore, come investimento iniziale,
rispetto a un impianto classico (una pompa sui 25 KW costa
circa 20.000 Euro), ma si dovrebbe ripagare in 7-8 anni, tenendo
conto del trend in crescita del prezzo del gasolio, che dovrebbe
in futuro rendere più conveniente il consumo di energia
elettrica rispetto a quello diretto di combustibile.
L'installazione ha un costo maggiore, come investimento iniziale,
rispetto a un impianto classico (una pompa sui 25 KW costa
circa 20.000 Euro), ma si dovrebbe ripagare in 7-8 anni, tenendo
conto del trend in crescita del prezzo del gasolio, che dovrebbe
in futuro rendere più conveniente il consumo di energia
elettrica rispetto a quello diretto di combustibile.
Il sistema di riscaldamento ottimale per questo tipo di impianto
è quello a pavimento, che necessita di soli 37-38°C
e si situa perciò nel range di maggiore rendimento
della pompa, mentre quello tradizionale a elementi raggianti
ha bisogno di 60-80°C. Inoltre, negli ultimi anni il rendimento
della pompa è passato da circa 1:2 (da 2 a 4 gradi),
a circa 1:4.
Durante l'estate le pompe possono anche essere usate al contrario
per cedere calore al sottosuolo e raffrescare l'ambiente.
Dato che si tratta di un riscaldamento "termodinamico",
totalmente esente da combustioni, si evitano emissioni di
calore e di inquinanti, nell'atmosfera e installazioni di
cisterne, causa di possibili perdite nel suolo. Naturalmente
vi è consumo di energia elettrica, ma a livello locale
l'impatto ambientale è nullo.
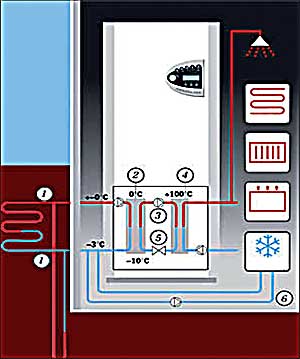
Dal
sottosuolo a temperatura T2 viene estratta una quantità
di calore Q2 che, tramite l'energia elettrica rappresentata
da L viene ceduto alla zona da riscaldare a temperatura
T1 sotto forma di Q1, che ingloba anche il calore in cui
viene trasformato L ed è quindi maggiore di Q2.
Nel
caso in esame sono stati realizzati 14 pozzi della profondità
di 105 m, con delle tubazioni che portano a un collettore
collegato alla pompa di calore. Nelle tubazioni circola acqua
addizionata con antigelo (glicole). A 105 m il terreno rimane
costantemente a 7-10°C, anche d'inverno. L'acqua, raggiunto
il sottosuolo, si porta a circa 10°C; risale e cede calore,
tramite uno scambiatore, al fluido frigorigeno della pompa
che evapora nell'evaporatore; l'acqua viene così raffreddata
a circa 0°C e riparte per il sottosuolo. Il liquido frigorigeno
viene poi compresso tramite motore elettrico riscaldandosi
e viene inviato al condensatore, dove cede il suo calore all'acqua
del riscaldamento o sanitaria condensandosi; infine si espande
e si raffredda nella valvola di laminazione, evaporando parzialmente.
Tramite due pompe che assorbono 25 KW e 17 KW allo spunto,
vengono riscaldate sia l'acqua sanitaria (4000 litri) che
l'acqua di riscaldamento (4000 litri).
*Ivan Castellani
Ingegnere ambientale, dottorato di ricerca (Ph.D.) in Energetica
|
